Ferrara era il confine del Nord per lo Stato Pontificio, il confine con Venezia e poi con l’Austria, tanto permeabile che a un certo punto gli austriaci ci si erano accasati. E’ il luogo psicologicamente e forse anche geograficamente più lontano da Roma. Anche con tutte le altre città del Regno del papa Ferrara faceva e fa un po’ confine, perché c’è entrata tardi e ha conservato una personalità distinta, tanto che ancora oggi, seppure si dà per scontato che non sia Romagna, si fatica anche un poco a metterla in Emilia. Ferrara è Ferrara, e forse basta così.
 Ferrara ha molti modi di essere confine. Il modo più semplice è quello delle mura estensi: ne abbiamo percorso un lungo tratto – almeno a me non è sembrato corto – dalla Porta degli angeli fino a Porta mare. E’ una di quelle passeggiate che possono permettersi solo le città più ben fatte, più previdenti, più aristocratiche anche. Ci ha sorpreso la quantità di persone che con scarpe da ginnastica, in tuta o in calzoncini e canottiera, camminavano, marciavano, correvano di lunedi mattina. E’ un tratto di campagna, qua e là anche abbastanza selvaggio, che cammina, in alto, attorno alla città, ovvero separa la sua parte più antica, più solida in certo modo, dalla periferia. E più che quell’umanità in cerca di salute fisica – per altro tante volte ho sentito di uomini che, passati i quaranta o i cinquant’anni, continuavano, o cominciavano magari, a fare questo giochetto del footing o jogging o come diavolo si chiama, e ci sono rimasti secchi d’un colpo – più che gli atleti che ci attorniavano e sorpassavano era sorprendente la vista delle automobili che correvano di fuori, sotto le mura, come pezzi di un’altra vita, la vita normale d’un giorno qualsiasi. Il tratto distintivo di Ferrara mi sembra una certa sua incapacità di essere qualsiasi.
Ferrara ha molti modi di essere confine. Il modo più semplice è quello delle mura estensi: ne abbiamo percorso un lungo tratto – almeno a me non è sembrato corto – dalla Porta degli angeli fino a Porta mare. E’ una di quelle passeggiate che possono permettersi solo le città più ben fatte, più previdenti, più aristocratiche anche. Ci ha sorpreso la quantità di persone che con scarpe da ginnastica, in tuta o in calzoncini e canottiera, camminavano, marciavano, correvano di lunedi mattina. E’ un tratto di campagna, qua e là anche abbastanza selvaggio, che cammina, in alto, attorno alla città, ovvero separa la sua parte più antica, più solida in certo modo, dalla periferia. E più che quell’umanità in cerca di salute fisica – per altro tante volte ho sentito di uomini che, passati i quaranta o i cinquant’anni, continuavano, o cominciavano magari, a fare questo giochetto del footing o jogging o come diavolo si chiama, e ci sono rimasti secchi d’un colpo – più che gli atleti che ci attorniavano e sorpassavano era sorprendente la vista delle automobili che correvano di fuori, sotto le mura, come pezzi di un’altra vita, la vita normale d’un giorno qualsiasi. Il tratto distintivo di Ferrara mi sembra una certa sua incapacità di essere qualsiasi.
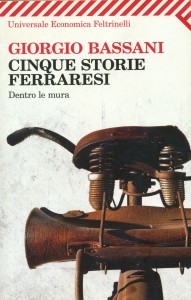 La sera prima, arrivati tardi nel pomeriggio, quattro ore, quasi cinque per fare i trecentocinquanta chilometri di autostrada – ma era la domenica dopo ferragosto, roba da bollino nero – dopo esserci sistemati all’Hotel Europa, dov’eravamo già stati e che per puro miracolo mi ero ritrovato a fianco della macchina dopo un po’ di giravolte in centro, siamo usciti sul corso della Giovecca e siamo andati verso il castello. Lì abbiamo girato per corso martiri della libertà. Ho cercato il Caffè della borsa, che non ho trovato e come tale, credo, non esiste più e poi, vincendo un pizzico di superstizione, siamo andati a leggere le lapidi sul muretto che -separa il marciapiede dal fossato del castello.
La sera prima, arrivati tardi nel pomeriggio, quattro ore, quasi cinque per fare i trecentocinquanta chilometri di autostrada – ma era la domenica dopo ferragosto, roba da bollino nero – dopo esserci sistemati all’Hotel Europa, dov’eravamo già stati e che per puro miracolo mi ero ritrovato a fianco della macchina dopo un po’ di giravolte in centro, siamo usciti sul corso della Giovecca e siamo andati verso il castello. Lì abbiamo girato per corso martiri della libertà. Ho cercato il Caffè della borsa, che non ho trovato e come tale, credo, non esiste più e poi, vincendo un pizzico di superstizione, siamo andati a leggere le lapidi sul muretto che -separa il marciapiede dal fossato del castello.
Il forestiero passa, e la gente seduta al caffè guarda e sogghigna. A certe ore della giornata, però, gli occhi si fissano in maniera particolare, i respiri addirittura si mozzano. Di che massacri immaginari non sono mai responsabili la noia e l’ozio della provincia?
Sotto il portico non c’era nessuno a guardarci. Non c’erano tavoli e non c’era neanche il caffè. Io però mi sono girato e ho guardato le finestre di fronte, quasi aspettassi il richiamo di Pino Barillari, il farmacista: “Badi a lei, giovanotto!”.
Lo svagato forestiero è appena in vista, e subito le conversazioni si fanno meno vivaci. Gli occhi si fissano, i respiri si mozzano. Si accorgerà, quel tale, prossimo a servirsi come se nulla fosse del marciapiede della fucilazione, di star compiendo un’azione da cui farebbe molto meglio ad astenersi? Alzerà o non alzerà finalmente la testa, colui, dalla Guida del Touring? Ma soprattutto scenderà o non scenderà a un dato punto dall’alto, aerea e assurda, ironica e triste, la voce dell’invisibile Pino Barillari?
Anche questa strada è un confine: lo è stata certamente fra la vita e la morte, fra fucilati e fucilatori, antifascisti e brigate nere. Ci lasciamo il castello alle spalle e procediamo verso il duomo, illuminato di notte. Adriana a un certo punto mi chiede: “Credi che ci sia ancora in giro un po’ di risentimento?”. Io non so rispondere ma mi accorgo all’improvviso che ovunque altrove la domanda potrebbe essere a sproposito, superata, inattuale: qui no, qui forse ha ancora un senso. Si ha un bel dire che i fascisti, quelli che hanno sparato, venivano da fuori, dal Veneto, da Verona, da Padova: chi ha detto di farlo, chi ha dato l’ordine, era di Ferrara. E questo è strano: che sembra successo ieri. Quello del tempo, mi pare, è il confine ferrarese più difficile da distinguere.
 Costeggiamo il fianco del duomo. Alle luci dei riflettori e dei lampioni di piazza Trento e Trieste si aggiungono rassicuranti le luci delle vetrine che corrono sotto il portico della chiesa: negozi non di lusso, sfarzo solo di lampadine, mercanti ingegnosi, fuori dal tempio, sì, ma accostati. Imbocchiamo via Mazzini, anche questa molto illuminata di botteghe e piuttosto allegra. Più avanti, sulla sinistra, il palazzo della sinagoga con la targa che ricorda i nomi degli ebrei ferraresi non tornati dai campi di sterminio nazisti. Ho cercato invano il nome di Geo Josz. Forse è riuscito a farlo cassare dalla lista quando è tornato dalla Germania, nell’estate del ’45, e nessuno se lo aspettava e quasi nessuno credeva che fosse davvero lui: però non vedo spazi bianchi, cancellati, nell’elenco. Forse ha addirittura preteso che la lapide fosse rifatta daccapo. Oppure Geo Josz non è mai esistito: è nato e vissuto solo nella fantasia di Giorgio Bassani. Fantasia, parola povera, buona a tutto e a niente, inadeguata a segnare il confine, molto stretto qui a Ferrara, fra l’immaginazione e la storia.
Costeggiamo il fianco del duomo. Alle luci dei riflettori e dei lampioni di piazza Trento e Trieste si aggiungono rassicuranti le luci delle vetrine che corrono sotto il portico della chiesa: negozi non di lusso, sfarzo solo di lampadine, mercanti ingegnosi, fuori dal tempio, sì, ma accostati. Imbocchiamo via Mazzini, anche questa molto illuminata di botteghe e piuttosto allegra. Più avanti, sulla sinistra, il palazzo della sinagoga con la targa che ricorda i nomi degli ebrei ferraresi non tornati dai campi di sterminio nazisti. Ho cercato invano il nome di Geo Josz. Forse è riuscito a farlo cassare dalla lista quando è tornato dalla Germania, nell’estate del ’45, e nessuno se lo aspettava e quasi nessuno credeva che fosse davvero lui: però non vedo spazi bianchi, cancellati, nell’elenco. Forse ha addirittura preteso che la lapide fosse rifatta daccapo. Oppure Geo Josz non è mai esistito: è nato e vissuto solo nella fantasia di Giorgio Bassani. Fantasia, parola povera, buona a tutto e a niente, inadeguata a segnare il confine, molto stretto qui a Ferrara, fra l’immaginazione e la storia.
 A Ferrara ci si perde facilmente, docilmente. E’ stato così che abbiamo camminato ancora a lungo, per vie meno illuminate e sempre più deserte. E se incontrassimo qualche malintenzionato? – ho pensato – magari anche solo un ubriaco, un poveraccio che ti si avvicina per chiedere una carità qualsiasi e tu di slancio ti ritrovi a dargli il portafogli. Abbiamo incontrato solo accompagnatori di cani: i ferraresi sono quasi tutti cinofili. E tuttavia le strade e i marciapiedi sono sempre puliti. Un cane ci ha abbaiato: perché gli camminavamo davanti, ci ha spiegato simpaticamente il padrone, che ovviamente lo conosce e sa che il suo cane non sopporta che qualcuno gli occupi la strada. Portano nomi affascinanti, le strade: il più bello di tutti via coperta. Non finiva mai e da tempo non sapevamo dov’eravamo e dove andavamo. “Ci siamo persi” ho detto ad Adriana. Ebbene sì, Ferrara di notte era un po’ come Terni di giorno e come Londra nei secoli dei secoli: un labirinto in cui non è che si perda l’orientamento, semplicemente non lo si acquista mai. Poco dopo, tuttavia, ci è apparso all’uscita d’un portone grande, importante, un gruppo di giovani. Avvicinandoci abbiamo sentito rumore di applausi: era evidentemente appena finito un concerto. Il palazzo lungo sulla strada, importante come il portone, come la corte alla quale ci siamo affacciati per un attimo, con l’intento quasi di non disturbare, era Schifanoia. Tutto mi aspettavo meno che arrivare lì. Adriana ha preso l’iniziativa – sa che io non chiederò mai nulla, a nessuno, sa che non mi piace il ruolo del turista perso, il ruolo che certamente tuttavia avevamo entrambi in quel momento – Adriana si è rivolta a un giovanotto per chiedergli la strada che ci avrebbe riportato in corso della Giovecca. “Andate diritti di qua, girate a destra per via Madama e andate sempre diritti fino a corso Giovecca, che però incontrerete ancora molto lontano dal centro”.
A Ferrara ci si perde facilmente, docilmente. E’ stato così che abbiamo camminato ancora a lungo, per vie meno illuminate e sempre più deserte. E se incontrassimo qualche malintenzionato? – ho pensato – magari anche solo un ubriaco, un poveraccio che ti si avvicina per chiedere una carità qualsiasi e tu di slancio ti ritrovi a dargli il portafogli. Abbiamo incontrato solo accompagnatori di cani: i ferraresi sono quasi tutti cinofili. E tuttavia le strade e i marciapiedi sono sempre puliti. Un cane ci ha abbaiato: perché gli camminavamo davanti, ci ha spiegato simpaticamente il padrone, che ovviamente lo conosce e sa che il suo cane non sopporta che qualcuno gli occupi la strada. Portano nomi affascinanti, le strade: il più bello di tutti via coperta. Non finiva mai e da tempo non sapevamo dov’eravamo e dove andavamo. “Ci siamo persi” ho detto ad Adriana. Ebbene sì, Ferrara di notte era un po’ come Terni di giorno e come Londra nei secoli dei secoli: un labirinto in cui non è che si perda l’orientamento, semplicemente non lo si acquista mai. Poco dopo, tuttavia, ci è apparso all’uscita d’un portone grande, importante, un gruppo di giovani. Avvicinandoci abbiamo sentito rumore di applausi: era evidentemente appena finito un concerto. Il palazzo lungo sulla strada, importante come il portone, come la corte alla quale ci siamo affacciati per un attimo, con l’intento quasi di non disturbare, era Schifanoia. Tutto mi aspettavo meno che arrivare lì. Adriana ha preso l’iniziativa – sa che io non chiederò mai nulla, a nessuno, sa che non mi piace il ruolo del turista perso, il ruolo che certamente tuttavia avevamo entrambi in quel momento – Adriana si è rivolta a un giovanotto per chiedergli la strada che ci avrebbe riportato in corso della Giovecca. “Andate diritti di qua, girate a destra per via Madama e andate sempre diritti fino a corso Giovecca, che però incontrerete ancora molto lontano dal centro”.
Lontano, sì, ma almeno va diritto anche lui e porta sempre lo stesso nome. Quando ci siamo arrivati ho girato gli occhi a sinistra e a destra, per essere sicuro della direzione da prendere: tanto non mi fidavo più della mia confidenza con i punti cardinali. Ed è stato solo quando ho intravvisto in lontananza la croce verde d’una farmacia che avevamo già incrociato all’arrivo in albergo, è stato allora che ho confermato: di qua, a sinistra. Dormito male: non per colpa dell’albergo, salvo forse per un antizanzare che odorava di caramella squagliata e certo non doveva piacere neanche alle zanzare. Dormito male per la stanchezza del viaggio, credo, e soprattutto, a essere sinceri, per un gran fritto di calamari, gamberi e alici “con le verdurine tutte nella loro pastella”, fra le quali verdurine le cipolle davano la musica a tutto il concerto: lì per lì neanche tanto male, poi però un disastro.

 La mattina dopo è quella della passeggiata che ho già detto. Ci eravamo arrivati dal corso Ercole I d’Este. L’acciottolato di multicolori sassi di fiume, più che per la comodità del viaggio, sembra fatto per ricordare l’unità e varietà della natura. Qua e là i sassi si diradano e lasciano una buca – si direbbe quasi una radura – che sembra di sabbia, più che di terra. Anche a Roma talvolta questo succede con i sampietrini: ma lì si pensa a turisti in cerca di ricordi un po’ più pesanti, agli stradini che, quando li hanno sistemati, non erano già più quelli di una volta, si pensa a mille ragioni diversamente umane e materiali. Qui ci si chiede quasi quale fiume sia venuto a riprenderseli, i sassi, questa o un’altra notte. Ci si chiede, con tutta naturalezza, quale marea minacci ancora la quiete di Ferrara.
La mattina dopo è quella della passeggiata che ho già detto. Ci eravamo arrivati dal corso Ercole I d’Este. L’acciottolato di multicolori sassi di fiume, più che per la comodità del viaggio, sembra fatto per ricordare l’unità e varietà della natura. Qua e là i sassi si diradano e lasciano una buca – si direbbe quasi una radura – che sembra di sabbia, più che di terra. Anche a Roma talvolta questo succede con i sampietrini: ma lì si pensa a turisti in cerca di ricordi un po’ più pesanti, agli stradini che, quando li hanno sistemati, non erano già più quelli di una volta, si pensa a mille ragioni diversamente umane e materiali. Qui ci si chiede quasi quale fiume sia venuto a riprenderseli, i sassi, questa o un’altra notte. Ci si chiede, con tutta naturalezza, quale marea minacci ancora la quiete di Ferrara.

 Palazzo dei diamanti: lavoro d’oreficeria gigantesca. Nessuna mostra in attesa d’una Barcellona di Picasso e Gaudì, che non mi consuma di desiderio. All’angolo di là dall’incrocio con corso Biagio Rossetti il Palazzo Prosperi Sacrati, con il suo portale e i suoi putti seduti sul balcone. Anche stavolta mi sono intrattenuto più con loro che con i diamanti. A mano a mano che si procede le costruzioni si abbassano e si fanno meno frequenti, la vegetazione prende senza fretta il sopravvento: è come se Ferrara distillasse la sua aria. Lunghi muri di mattoni rossi. Case di due piani, d’un’aristocrazia magari recente, ma distinta per semplicità. Inutile chiedersi quale sia il muro di cinta del giardino dei Finzi Contini.
Palazzo dei diamanti: lavoro d’oreficeria gigantesca. Nessuna mostra in attesa d’una Barcellona di Picasso e Gaudì, che non mi consuma di desiderio. All’angolo di là dall’incrocio con corso Biagio Rossetti il Palazzo Prosperi Sacrati, con il suo portale e i suoi putti seduti sul balcone. Anche stavolta mi sono intrattenuto più con loro che con i diamanti. A mano a mano che si procede le costruzioni si abbassano e si fanno meno frequenti, la vegetazione prende senza fretta il sopravvento: è come se Ferrara distillasse la sua aria. Lunghi muri di mattoni rossi. Case di due piani, d’un’aristocrazia magari recente, ma distinta per semplicità. Inutile chiedersi quale sia il muro di cinta del giardino dei Finzi Contini.
 L’unico posto sicuro in cui cercare Bassani è la sua tomba. E noi lì volevamo arrivare. Per questo tutto il giro delle mura, o della Mura degli angeli, come scrive lui, per questo il rientro da Porta mare, a cercare la via delle vigne.
L’unico posto sicuro in cui cercare Bassani è la sua tomba. E noi lì volevamo arrivare. Per questo tutto il giro delle mura, o della Mura degli angeli, come scrive lui, per questo il rientro da Porta mare, a cercare la via delle vigne.
Il cancello è in fondo, alla volta della strada. L’ingresso è sulla destra, con il portoncino e il campanello che bisogna suonare. Adriana suona. Pochi attimi e ci apre una signora che avrà più o meno l’età nostra. Ci fa firmare il registro delle visite. Mia moglie, alla casella della provenienza, scrive: Roma. Che non sarebbe neppure del tutto sbagliato, considerato che è da lì che proviene, essendoci nata. Tutte le altre volte, però, in questi due anni ha scritto: Magliano Sabina. Cos’è allora questa novità? Mi chiedo. Come se a Ferrara, al cimitero ebraico di Ferrara, Magliano non bastasse, come se Magliano fosse fuori da questa partita, troppo grande per lei, come se solo Roma potesse reggere il confronto. Non gliene chiedo ragione: metto la mia firma e le virgolette sotto a Roma. Prendo una kippah dal panierino sul tavolo dove sono ammucchiate. Me la metto in testa e per un po’ la tengo con la mano sui capelli. Entriamo. Riusciamo, meglio, in quest’aria ormai tutta distillata di Ferrara.
 Non abbiamo chiesto alla signora dove sia la tomba di Bassani. Il solito pudore di non chiedere indicazioni. “Ecco altri due che vengono per Bassani”: questo, pensavo, avrebbe detto la signora e ci avrebbe inquadrato nella categoria dei turisti, magari letterari, ma sempre turisti. Goim, gentili, gente estranea e di passaggio: questo saremmo stati. Questo certamente eravamo, almeno in parte: ma il nostro scopo, se ce n’era uno, era meno preciso e forse più largo che segnare il punto fermo dove Giorgio Bassani è sepolto. Credo che volessimo far visita al suo popolo, com’era, come lui stesso lo ha ricordato e ce l’ha ricordato. “Credi che ci sia ancora in giro un po’ di risentimento?”. Qui no, qui non si avverte: l’aria è davvero troppo distillata. Leggo qualche lapide, come fa chiunque entri in un cimitero. Due tombe appaiate:
Non abbiamo chiesto alla signora dove sia la tomba di Bassani. Il solito pudore di non chiedere indicazioni. “Ecco altri due che vengono per Bassani”: questo, pensavo, avrebbe detto la signora e ci avrebbe inquadrato nella categoria dei turisti, magari letterari, ma sempre turisti. Goim, gentili, gente estranea e di passaggio: questo saremmo stati. Questo certamente eravamo, almeno in parte: ma il nostro scopo, se ce n’era uno, era meno preciso e forse più largo che segnare il punto fermo dove Giorgio Bassani è sepolto. Credo che volessimo far visita al suo popolo, com’era, come lui stesso lo ha ricordato e ce l’ha ricordato. “Credi che ci sia ancora in giro un po’ di risentimento?”. Qui no, qui non si avverte: l’aria è davvero troppo distillata. Leggo qualche lapide, come fa chiunque entri in un cimitero. Due tombe appaiate:
LETIZIA CALABRESI
20 1 1890 19 9 1979
Questa si è dunque salvata: è morta a quasi novant’anni. E quest’altra era la madre?
IDA FANO
CALABRESI
1 7 1854 27 12 1943
E’ campata lo stesso tempo, giorno più, giorno meno: famiglia di forte fibra. Ma quella data in fondo, quel dicembre del ’43, apre forse qualche dubbio sul modo di morire. Guardo ancora in giro per le lapidi e dopo un po’, curiosamente, mi trovo a sorprendermi di tutti quelli che non sono morti allora o nel tempo immediatamente appresso. Mi sorprende perfino questo Pico Deodato Cavalieri, classe 1874, “capitano pilota aviatore”, che “qui dorme in eterno” dopo essere morto in guerra, nel 1917, perché “entusiasta assertore d’italianità, alla gran madre che lo chiamava – evidentemente l’Italia – offerse la vita eroicamente”. Se non gli fosse capitato quell’incidente, avrebbe forse fatto in tempo a diventare fascista e a pentirsene. Molti ebrei erano fascisti – Bassani lo ricorda spesso – la maggioranza degli italiani è stata fascista: perché gli ebrei no?
Non trovo, perché non la cerco e perché non c’è, la tomba dei Finzi Contini:
La tomba era grande, massiccia, davvero imponente: una specie di tempio tra l’antico e l’orientale, come se ne vedeva nelle scenografie dell’Aida e del Nabucco in voga nei nostri teatri d’opera fino a pochi anni fa.
Penso che se ci fosse rassomiglierebbe anche al King David di Gerusalemme. Continuando la perlustrazione sul largo viale d’erba, mi accorgo che i cognomi Finzi e Contini stanno sparsi su due gruppi di tombe, prossimi e quasi in dimestichezza fra loro. Che sia qui, fra i morti, che è nato il nome? Ripenso al romanzo, che è di lancinante bellezza. Ricordo l’incubo d’una cena pasquale che al protagonista senza nome sembra un Kippur:
Perché non mi sottraevo subito a quel disperato e grottesco convegno di spettri, o almeno non mi turavo le orecchie per non sentir più parlare di “discriminazioni”, di “meriti patriottici”, di “certificati d’anzianità”, di “quarti di sangue”, per più non udire la gretta lamentela, la monotona, grigia, inutile trenodia che parenti e consanguinei intonavano sommessi attorno? La cena si sarebbe trascinata così, fra discorsi rimasticati, chissà per quante ore, con mio padre ogni poco rievocante, amaro e deliziato, i vari “affronti” che aveva dovuto subire nel corso di quegli ultimi mesi, a cominciare da quando, in Federazione, il Segretario Federale, console Bolognesi, gli aveva annunciato con occhi colpevoli, addolorati, di essere costretto a “cancellarlo” dalla lista degli iscritti al Partito, per finire a quando, con occhi non meno rattristati, il presidente del Circolo dei Negozianti lo aveva convocato per comunicargli di dover considerarlo “dimissionario”. Ne avrebbe avute, da raccontare! Fino a mezzanotte, fino all’una, fino alle due! E poi? Poi ci sarebbe stata la scena ultima, quella degli addii. Già la vedevo. Eravamo scesi tutti in gruppo giù per le scale buie, come un gregge oppresso. Giunti nel portico, qualcuno (forse io) era andato avanti, a socchiudere il portone di strada, ed ora, per l’ultima volta, prima di separarci, si rinnovavano da parte di tutti, me compreso, i buonanotte, gli auguri, le strette di mano, gli abbracci, i baci sulle gote. Senonché, improvvisamente, dal portone rimasto mezzo aperto, là, contro il nero della notte, ecco irrompere dentro il portico una raffica di vento. E’ vento d’uragano, e viene dalla notte.
 Ho tardato tanto a leggere Bassani. M’ero fatto l’idea che la lettura potesse risultare triste: e poi ho visto che l’idea non era così sbagliata. Per primo ho letto Gli occhiali d’oro: ed era un suicidio. Suicidio dolcissimo, se così si può dire, un suicidio mite. Poi Dietro la porta e le Cinque storie ferraresi e L’airone, che ho dovuto smettere, perché qua e là e spesso, o quasi sempre, faceva male: ci ho messo molto tempo a riprenderlo e a capire che è probabilmente il più bel romanzo di Bassani. Mi resta un piccolo dubbio solo a confrontarlo con Il giardino dei Finzi-Contini, con le storie di Micòl, di Alberto, del professor Ermanno e anche di quell’altro padre, il padre del protagonista, apparentemente così ingenuo, ottuso nel suo fascismo tradito e deluso. Verso la fine del racconto aspetta sveglio che il figlio rincasi, tardi nella notte. E’ il momento che ha per parlargli dell’amore per Micòl, che non era per lui e che non è neppure davvero cominciato:
Ho tardato tanto a leggere Bassani. M’ero fatto l’idea che la lettura potesse risultare triste: e poi ho visto che l’idea non era così sbagliata. Per primo ho letto Gli occhiali d’oro: ed era un suicidio. Suicidio dolcissimo, se così si può dire, un suicidio mite. Poi Dietro la porta e le Cinque storie ferraresi e L’airone, che ho dovuto smettere, perché qua e là e spesso, o quasi sempre, faceva male: ci ho messo molto tempo a riprenderlo e a capire che è probabilmente il più bel romanzo di Bassani. Mi resta un piccolo dubbio solo a confrontarlo con Il giardino dei Finzi-Contini, con le storie di Micòl, di Alberto, del professor Ermanno e anche di quell’altro padre, il padre del protagonista, apparentemente così ingenuo, ottuso nel suo fascismo tradito e deluso. Verso la fine del racconto aspetta sveglio che il figlio rincasi, tardi nella notte. E’ il momento che ha per parlargli dell’amore per Micòl, che non era per lui e che non è neppure davvero cominciato:
“Ti passerà,” continuava, “ti passerà, e molto più presto di quanto tu non creda. Certo, mi dispiace: immagino quello che senti in questo momento. Però un pochino anche t’invidio, sai? Nella vita, se uno vuol capire, capire sul serio come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta. E allora, dato che la legge è questa, meglio morire da giovani, quando uno ha ancora tanto tempo davanti a sé per tirarsi su e risuscitare… Capire da vecchi è brutto, molto più brutto. Come si fa? Non c’è più tempo per ricominciare da zero, e la nostra generazione ne ha prese talmente tante, di cantonate! Ad ogni modo, se Dio benedetto vuole, tu sei così giovane! Tra qualche mese, vedrai, non ti sembrerà neanche vero di essere passato in mezzo a tutto questo. Sarai magari perfino contento. Ti sentirai più ricco, non so… più maturo…”
Conservare l’ingenuità, pur riconoscendo le cantonate prese, e con la stessa ingenuità offrire consolazione al figlio – come fosse un buon miraggio per un innamorato la prospettiva di smettere di esserlo, l’ipotesi di scordarsene – e fare uscire speranza dal cuore della più desolata disperazione: questo è il massimo che un padre possa dare a un figlio. Mi viene in mente Monaldo Leopardi: il conte di Recanati e il commerciante di Ferrara sono in fondo uguali. “Assicuratevi, Figlio mio, che in tutti, ma segnatamente negli uomini di talento e d’immaginazione, la fantasia, per troppo prevedere i mali, li produce non raramente, e che un poco di balordaggine non è un ingrediente pessimo nella composizione della vita”. Il che può voler dire anche che non c’è uno specifico modo d’essere ebraico e un altro cristiano, o gentile. Vuol dire anche che tutti i padri sono accomunati nella stessa ingenuità, offerta ai figli come speranza o almeno come consolazione.
Abbiamo girato per la parte, pare, più vecchia e anche più riservata del cimitero. Qui le lapidi stanno diritte – non tutte perfettamente – piantate nel terreno. Prima sono fitte, poi si diradano in un largo prato. Si dovrà pur riconoscere la tomba che cerchiamo se, come ho letto, l’ha fatta Arnaldo Pomodoro. E si riconosce, infatti, ma non tanto per la forma che ancora si distingue appena, quanto per il posto che non può essere che il suo: laggiù, oltre la fine del vialetto, fra il muro e una fila di pioppi cipressini.
GIORGIO BASSANI
4 MARZO 1916 13 APRILE 2000
 Sopra la lastra di bronzo, all’uso ebraico, sono stati deposti sassi. Su qualcuno si legge ancora il nome di chi l’ha portato. Su uno vedo scritto “Federica e Stefano” e sotto disegnato un cuoricino. Non so decidere se il cuoricino sia per lui, Bassani, o per loro due: magari è per tutti e tre. Su un altro hanno scritto “Grazie tante! Un grande scrittore!” e poi qualcosa in tedesco. Adriana prende due piccoli sassi dal brecciolino e me ne dà uno. Sarebbe stato meglio – ho pensato – portarlo almeno dalla Corsica. Bastava pensarci, meno di un mese fa. Non l’ho fatto, pazienza: contentiamoci di questi. E’ bello, m’è sempre piaciuto, l’uso ebraico. E spero di poter tornare un giorno a Gerusalemme e portare un sasso al mio amico Willy Molco. Però, quanto al “Grazie tante!”, sono improvvisamente assalito da un dubbio: ma lo devo davvero ringraziare? per quanto sono stato male con Edgardo Limentani e co
Sopra la lastra di bronzo, all’uso ebraico, sono stati deposti sassi. Su qualcuno si legge ancora il nome di chi l’ha portato. Su uno vedo scritto “Federica e Stefano” e sotto disegnato un cuoricino. Non so decidere se il cuoricino sia per lui, Bassani, o per loro due: magari è per tutti e tre. Su un altro hanno scritto “Grazie tante! Un grande scrittore!” e poi qualcosa in tedesco. Adriana prende due piccoli sassi dal brecciolino e me ne dà uno. Sarebbe stato meglio – ho pensato – portarlo almeno dalla Corsica. Bastava pensarci, meno di un mese fa. Non l’ho fatto, pazienza: contentiamoci di questi. E’ bello, m’è sempre piaciuto, l’uso ebraico. E spero di poter tornare un giorno a Gerusalemme e portare un sasso al mio amico Willy Molco. Però, quanto al “Grazie tante!”, sono improvvisamente assalito da un dubbio: ma lo devo davvero ringraziare? per quanto sono stato male con Edgardo Limentani e co
n l’airone ferito? Se si ringraziano tutti gli scrittori bravi, quelli che ci svegliano i sentimenti, che ce li fanno immaginare o ricordare, i grandi autori, insomma, di bellezza e di sofferenza, che cosa si dovrebbe fare con quelli che ci fanno compagnia?
 E non ci ha fatto compagnia, Bassani, ieri e oggi? La lettura no: la lettura è un’altra cosa. Quella è fatica. Non potrei mai leggere dieci pagine di Bassani a letto prima di prendere sonno: non prenderei sonno o dormirei male. Però anche lui ormai mi fa compagnia. Così, mentre poso la kippah nel cestino e mi avvio all’uscita, mentre riprendiamo via delle vigne e all’incrocio con il corso di Porta mare andiamo diritti per via Montebello, abbiamo già deciso che la nostra visita a Ferrara – la terza? la quarta? – sta per finire. Santa Maria in Vado? Schifanoia? Adesso no. Siamo stanchi. Sarà per un’altra volta. Vorrei piuttosto adesso inseguire il mio autore verso un altro confine: riprendere la macchina in albergo e rifare almeno in parte il cammino di quella mattina di dicembre – sempre dicembre – quando Edgardo Limentani decise di riandare a caccia. Così cerchiamo la strada per Codigoro, diritta, stretta e lunga, fra due file di platani. E arriviamo a Codigoro e ci fermiamo per qualche minuto nella sua grande, scomposta, un po’ assurda piazza. Confine di terra e acqua, confine per eccellenza. Ma quanto l’amava, Bassani, la sua Ferrara? Chissà. Certo, a pagina 50, Limentani è combattuto fra l’idea di andare avanti e quella di tornare indietro:
E non ci ha fatto compagnia, Bassani, ieri e oggi? La lettura no: la lettura è un’altra cosa. Quella è fatica. Non potrei mai leggere dieci pagine di Bassani a letto prima di prendere sonno: non prenderei sonno o dormirei male. Però anche lui ormai mi fa compagnia. Così, mentre poso la kippah nel cestino e mi avvio all’uscita, mentre riprendiamo via delle vigne e all’incrocio con il corso di Porta mare andiamo diritti per via Montebello, abbiamo già deciso che la nostra visita a Ferrara – la terza? la quarta? – sta per finire. Santa Maria in Vado? Schifanoia? Adesso no. Siamo stanchi. Sarà per un’altra volta. Vorrei piuttosto adesso inseguire il mio autore verso un altro confine: riprendere la macchina in albergo e rifare almeno in parte il cammino di quella mattina di dicembre – sempre dicembre – quando Edgardo Limentani decise di riandare a caccia. Così cerchiamo la strada per Codigoro, diritta, stretta e lunga, fra due file di platani. E arriviamo a Codigoro e ci fermiamo per qualche minuto nella sua grande, scomposta, un po’ assurda piazza. Confine di terra e acqua, confine per eccellenza. Ma quanto l’amava, Bassani, la sua Ferrara? Chissà. Certo, a pagina 50, Limentani è combattuto fra l’idea di andare avanti e quella di tornare indietro:
Eppure no, non doveva cedere, rassegnarsi. L’idea di rincasare immediatamente, che di nuovo tornava a tentarlo, questa volta fu pronto a scartarla, senza esitazione di sorta. Ripercorrere in senso contrario la strada piena di curve che aveva percorso poco fa, ripassare sotto Pomposa, riattraversare Codigoro o quanto meno girarle attorno, e infine, verso le undici, scorgere profilarsi di lontano le quattro torri del castello Estense: tutto questo non sarebbe valso che a ripiombarlo, non ne aveva il più piccolo dubbio, in fondo a quel medesimo cupo pozzo di tristezza accidiosa da cui a un certo punto aveva creduto di essere emerso definitivamente.
Non so a lui – a Bassani, dico – ma a me il castello proprio non piace.
